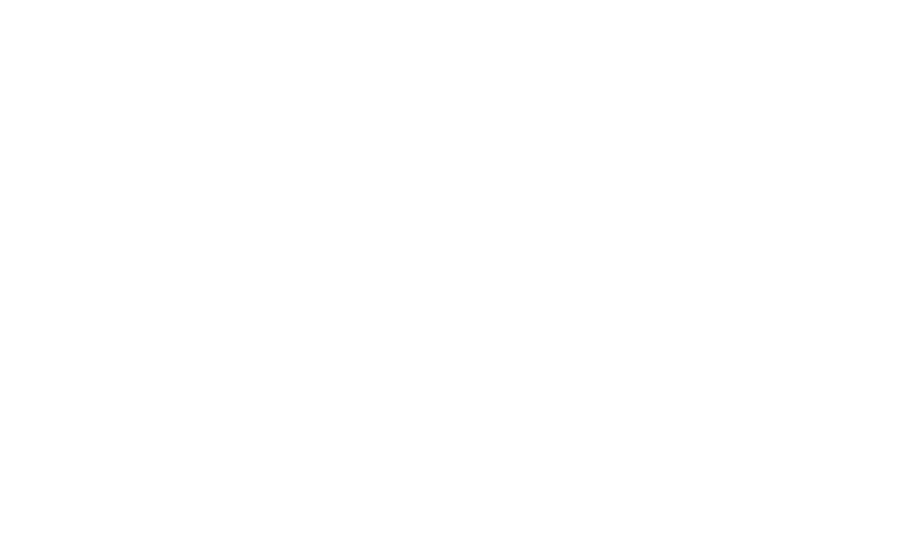
Ci ha lasciati qualche giorno fa (lasciamo ai ricercatori di Wikipedia il compito di scoprire quando) Marco Vicario. In totale silenzio, tanto che la notizia non è trapelata, com’era nello spirito di un uomo che aveva fatto della riservatezza il suo stile di vita. In un mondo in cui tutti vogliono apparire, Marco Vicario ha attuato una progressiva tecnica della sparizione, pur continuando a lavorare fino all’ultimo. Quasi un paradosso per un uomo di cinema che aveva cominciato come attore, dopo aver studiato recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Allora si chiamava Renato Vicario, ma il caso volle che ci fosse già nell’ambiente un omonimo attore, il quale gli chiese di cambiare nome. A nulla valse l’obiezione che il primo Renato Vicario fosse sì un attore, ma di fotoromanzi. Non deve essere però dispiaciuto a Renato Vicario diventare Marco Vicario (da allora quasi una sigla), al punto che tutti lo chiameranno sempre così. Un modo per separarsi da se stesso, chiudere un capitolo della propria vita, di cui nessuno ha mai saputo nulla, e aprirne un altro.
Venticinque film da attore, o giù di lì, lungo gli anni '50. Una bella faccia, sulla scia di Franco Interlenghi, buona per le commedie come per i film drammatici che consumavano gli ultimi furori neorealisti. Sulla sua carriera di interprete Marco Vicario sorvolava con nonchalance, come fosse un peccato di gioventù, ma varrebbe la pena oggi rivederlo almeno in Saranno uomini di Silvio Siano e in Giovane canaglia di Giuseppe Vari, suo ultimo film da attore e primo da produttore. Nella sua seconda (o terza) vita intraprende parallelamente la carriera di regista e produttore. Produce (con la sua Atlantica Cinematografica) e dirige un documentario, un mondo-movie, Il pelo nel mondo, insieme a Antonio Margheriti, alias Anthony M. Dawson, al quale produce vari film, tra i quali La vergine di Norimberga. Vicario, uomo di classe, si nasconde dietro uno pseudonimo, Renato Marvi, giocando con il nome d’arte, il nome vero e la contrazione del cognome. Vezzi, ma anche la consapevolezza di poter aspirare a qualcosa di più.
Marco Vicario diventa il Marco Vicario che tutti conosciamo con Le ore nude, 1964, nel pieno della riflessione esistenziale di Michelangelo Antonioni applicata al cinema, i cui echi giungono fino a Capalbio, ancora incontaminata da intellettualismi vari. Una giovane donna sveste per poche ore i panni della moglie, attratta da uno studente, e quando li indosserà nuovamente, tornando dal marito, non sarà più la stessa. Philippe Leroy e Rossana Podestà sono le coordinate ideali del cinema di Marco Vicario, che rivela una mano ispirata riempiendo il racconto di Alberto Moravia, Appuntamento al mare, degli umori di un’epoca sbarazzina.
Un giorno, percorrendo via Condotti, ha l’intuizione della sua vita: vede degli operai che stanno lavorando davanti a Bulgari e pensa che potrebbe essere una soluzione ideale per svaligiare la famosa gioielleria. Non nella realtà, ovviamente, ma nella finzione e in pochi giorni, facendo leggere quello che scrive alle sue segretarie, compone una sceneggiatura ad orologeria, mette su una troupe e con pochi soldi parte all’avventura. Senza alcun permesso inizia a girare nella Ginevra delle banche la storia di un colpo miliardario, salvo essere scoperto dalla polizia ed essere costretto a completare le riprese nel giro di un weekend, organizzando tante piccole troupe al lavoro in contemporanea. Un film nel film e un colpo nel colpo. Nasce così Sette uomini d’oro, uno dei successi più clamorosi del cinema italiano nel mondo, subito bissato da Il grande colpo dei 7 uomini d’oro. Film imitatissimi, in un’epoca, seconda metà degli anni '60, in cui, complice il boom economico, in tanti sognano il colpo della vita. L’unico a realizzarlo veramente è Marco Vicario, che si può permettere di inanellare film di successo, con una particolare ispirazione per i titoli, capaci di riflettere gli umori di una società che cambia pelle sotto i colpi della rivoluzione sessuale: Il prete sposato, Homo eroticus, Paolo il caldo, L’erotomane, Mogliamente. Su questi film, come pure sugli ultimi, Il cappotto di Astrakan e Scusa se è poco, con i quali scavalla gli anni '70, Marco Vicario non amava dilungarsi, reputandoli prodotti commerciali, malgrado gli ottimi cast e le ascendenze letterarie di alcuni di essi.
Nella sua filosofia del lavoro, sempre improntato al “farò” e mai a quello che “ho fatto”, si concedeva solo il piacere di parlare de I sette uomini d’oro, ma più per raccontare l’impresa realizzata che per il film in sé. Non si parlava addosso e lasciava agli altri i giudizi. Era però attaccatissimo ai suoi film, dai quali non si è mai voluto separare, mantenendo i diritti delle sue produzioni, senza (s)venderli alle televisione, convinto dentro di sé che il modo migliore per preservarli, a futura memoria, fosse proprio non farli circolare, piuttosto che infilarli nel filmificio creato dalle tv commerciali. Oggi sarebbe il caso di rivederli ad uno ad uno per comprendere la reale cifra stilistica di un regista che, malgrado i suoi pudori, è stato un autore. E un modello produttivo da studiare, appartenendo alla rara cerchia dei produttori italiani – come Ugo Tucci, che ha condiviso con lui l’esperienza dei sette uomini d’oro –, senza macchia, ovvero senza essere mai caduto al botteghino.
Con lungimiranza, agli inizi degli anni '80, quando si è reso conto, prima degli altri, che il cinema italiano non avrebbe retto all’urto delle televisioni e alla morte dei generi, si è (apparentemente) ritratto, smettendo i panni del regista, ma non del produttore. Ha diversificato la sua attività, lanciandosi nel campo della pubblicità, soprattutto in Francia, con i suoi vecchi partner produttivi. E in silenzio, come piaceva a lui, ha continuato a lavorare con grandi soddisfazioni personali, sparendo dai radar del cinema italiano: la sua terza (o quarta) vita, di cui nessuno ha mai saputo nulla.
Qualche anno fa, con grande generosità, in ricordo dei suoi trascorsi da allievo, Marco Vicario ha consentito al Centro Sperimentale di Cinematografia di restaurare il film della sua vita, I sette uomini d’oro, presentato alla Casa del Cinema il 27 novembre 2018. Dopo anni di silenzio, in quell’occasione, forse per la prima volta emozionato, prese la parola e ha raccontato i segreti di un film leggendario, alla presenza di Philippe Leroy. È stato il suo commiato, anche se il giorno dopo era di nuovo, regolarmente, al lavoro, a pensare ai progetti futuri.
Il 20 settembre avrebbe compiuto 95 anni, ma da tempo si era scrollato di dosso l’anagrafe, mantenendo uno spirito (e un fisico) da ragazzo.
Non lo dimenticheremo.

 Accedi/Registrati
Accedi/Registrati Carrello
Carrello









 SHARE
SHARE
Condividi